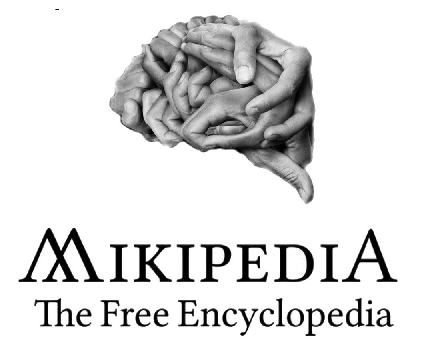Da quando è iniziata questa emergenza l’Italia (e il mondo) hanno scoperto la medicina d’urgenza e la terapia intensiva. Ora chiunque sa cosa fa un anestesista, la differenza tra una mascherina chirurgica e un filtrante, come funziona la ventilazione non invasiva, perché è utile pronare un malato e molte altre cose ultraspecialistiche. Si dà il caso che io faccia il medico d’urgenza e che quindi mi risulti facile raccontare cosa avviene ogni giorno in ospedale, ma c’è una parte della realtà medico-assistenziale più nascosta e ignorata dalla retorica dei media, negletta da sempre e difficilissima da proteggere. Quello che state per leggere è un guest post scritto da S. mio compagno di università e amico che si trova a fronteggiare la stessa emergenza in un ambito completamente diverso dal mio.
Ecco a voi il Covid19 con gli occhi di chi lavora in una comunità psichiatrica.
D. sta passando le due settimane più belle della sua vita. O almeno le più belle da quando è qui. La quarantena è la sua Disneyland.
Ridiamo, rigorosamente dietro uno schermo. Oggi sarà la quarta ora consecutiva che passo davanti a uno schermo. Con lo schermo in quarantena facciamo tutto: cene, sexting e lavoro. Tutto su skype, whatsapp, zoom. Divertente. Quando finalmente finirò di lavorare, potrò mettere su i felafel e, neanche a dirlo, riaccendere il computer e continuare a guardare il film da dove l’ho lasciato. Questi vendicatori hanno portato decisamente scompiglio a New York e, sinceramente, credo che qualcuno debba far prendere a quel Nick qualcuna delle sue responsabilità. Tutto attraverso lo schermo.
Parlavamo di D.
D. Non è propriamente un mio paziente. È ospite di una comunità dove, proprio a ridosso della pandemia, avevo iniziato a fare formazione e supervisione. È molto difficile rispondere alla domanda “Che medico sei?” quando mi viene rivolta.
Se avessi avuto un percorso più lineare (specializzazione, contratto da strutturato) sarebbe più semplice: “Faccio l’endocrinologo, ambulatorio diabetologia”. Invece sono uno di quei “camici grigi”, lavoro a partita iva, mai visto un contratto di assunzione e mi trovo a cambiare spesso lavoro, un po’ perché così è questa fetta del mercato, un po’ perché sono così io e in questa fluidità alla fine ci sguazzo pure troppo. Però ce la stavo facendo ad avere una qualche forma di stabilità, un qualche piano, tra strutture residenziali, formazione, giro di sostituzioni e turni in clinica. Poi SarsCov2 è arrivato in Europa e quasi tutti i miei lavori sono stati cancellati o, quando va bene, si sono trasformati in qualcos’altro, una sorta di manager reperibile 24/7.
In questa strana quotidianità ho dovuto confrontarmi con il virus in modi molto diversi e mi sono trovato a improvvisare risposte, con la sensazione di essere solo e senza indicazioni. Dai genitori degli ambulatori pediatrici che mi ponevano domande sulla prozia ricoverata, al servizio di educativa territoriale che, pre-confinamento, mi chiede una realistica valutazione del rischio di una pizzata in Val Chisone. Pian piano che abbiamo visto attorno a noi le cose cambiare e i toni dei media ci hanno pitturato una realtà diversa, le preoccupazioni sono cambiate e i quesiti pure. “Ma sarà sto covid?” e “Come facciamo con le mascherine? Servono?”
Sono iniziati i ricoveri. In una “mia” comunità R., a fine febbraio, è stato ricoverato due volte per polmonite interstiziale. Anche se ospedalizzato, non gli è stato fatto il tampone. Sarà covid? Probabile, ma se dico probaile cosa capiranno? Capiranno Sì” o capiranno “Probabile”? Rispondo la verità, e l’incertezza non piace mai come risposta quando viene da un medico. “Non c’è la diagnosi, ma la sintomatologia è compatibile, come anche i risultati degli esami. Ma potrebbe essere anche altro.” Si sente dal tono della mia voce che ci credo veramente poco.
Con il ricovero di R. sono iniziate le mutue: ai coordinatori è venuto il sospetto che non sempre siano davvero giustificate e qualcuno si metta in mutua per paura. Dai dati che abbiamo, però, il contagio tra operatori sanitari è altissimo, per cui sì, ci si ammala a lavoro e ci si ammala tanto. Con le mutue sono comparse le soluzioni fantasiose per coprire i turni dei servizi residenziali, mentre i servizi non residenziali hanno dovuto chiudere (e con loro una parte del mio reddito del mese se n’è andato, così).
I lavoratori sono spaventati e chiedono risposte che non riesco a dare. Si vocifera che nel torinese abbiano chiesto a dei lavoratori sintomatici di mettersi in quarantena direttamente in struttura, dopo essere stati a contatto con ospiti covid+. Si dice che sia stato chiesto di passare due settimane in quarantena con gli utenti, per non aumentare il contagio a nuovi lavoratori. Una prospettiva che fa paura e che terrorizza quasi quanto la paura di portare il contagio ai propri affetti e ai propri cari.
Intanto il telefono squilla, le skype call si moltiplicano, la logistica dell’approvvigionamento dei DPI diventa la sfida del mese. Il fatto di avere utenti con disabilità importanti, spesso sindromici e con quadri di immunodepressione e fragilità, non cambia la burocrazia secondo cui noi siamo un servizio non sanitario e quindi i dispositivi arriveranno, se e quando ci saranno, dopo tutti gli altri. Le priorità sono altre, ci sentiamo dire da ormai un mese.
Forse sono pure d’accordo. Ho fatto 6 giorni di sostituzioni con un’unica mascherina chirurgica, trafugata da una collega, sotto giuramento di non rivelare mai la fonte. E infatti mi sono sono inevitabilmente ammalato e ho fatto la quarantena.
Forse è giusto che arriviamo dopo ogni ospedale, ogni ambulatorio, ogni servizio sanitario in senso stretto. Ma se uno dei miei pazienti venisse ospedalizzato, per colpa della mia scarsa capacità di organizzare e fornire ai lavoratori gli strumenti per non portare il contagio in comunità, sarebbe candidato più alla palliazione che alla rianimazione e alle cure intensive.
Da quando R. ha avuto la recidiva ho iniziato ad avere l’insonnia. Come vi dicevo, sono un medico un po’ particolare. Spesso lavoro più con le equipe delle mie strutture che con gli ospiti, ma il sorriso di R. me lo ricordo. Mi ricordo quando ci siamo incontrati: sorriso sdentato, andatura steppante e succo di frutta da portare in sala riunioni, (ve le ricordate le sale riunioni? Non zoom, sale riunioni). È stata la mia ultima pausa caffé in comunità, quasi due mesi fa.
R. ormai sta bene. Ma la mia insonnia continua. Le cose più semplici, come la gestione della riabilitazione dopo una caduta, sono diventate sfide insormontabili. Grandi e piccoli problemi ormai sono una mole inestricabile di preoccupazioni da sbrogliare e gestire con quel briciolo di lucidità rimasta.
Ed è al ricovero di R. che penso mentre mi aggiornano su D. D. non l’ho conosciuto direttamente, anche se il suo caso mi è stato esposto poco prima che venisse isolato. Gestire in comunità un isolamento non è semplice, soprattutto quando non tutti gli ospiti hanno le capacità cognitive per capire gli stravolgimenti che avvengono attorno a loro.
Questa nuova routine, segregati e senza poter uscire, ricorda la gestione pre-Basaglia e ci fa paura pure dirlo. Certamente non per tutti, ma per i casi più gravi sì. Sono aumentate le prescrizioni farmacologiche e i dosaggi, mentre vediamo scomparire le attività e gli strumenti psicoeducativi messi in piedi con tanta fatica. Gli ospiti litigano per portare l’immondizia fuori. In un caso uno di questi litigi è diventata agitazione vera e propria, e ha richiesto un accesso in DEA, con tutte le preoccupazioni che da un accesso in DEA oggi derivano. Ai tempi del sarscov2, decidere chi butterà l’immondizia è un problema clinico che occupa risorse mentali e tempo. Chi l’avrebbe detto!
Però D. è felice. Un bambino confinato in una sala piena di cuscini, riadattata a camera da letto, circondato di attenzioni e, finalmente indisturbato, libero di sfogare le sue fissazioni: battere ritmicamente i libri uno con l’altro e far suonare i suoi carillion.
Ma D. non è il motivo della chiamata. C’è qualcosa di più complicato da discutere.
La questione DPI è questione di vita e di morte, letteralmente. Gli operatori in alcuni casi imboccano gli ospiti, fanno loro l’igiene. Il rischio di portare qualcosa da fuori è altissimo.
“Sono arrivate le mascherine della protezione civile”.
Sento il battito cambiare il suo ritmo. Forse possiamo tirare un sospiro di sollievo. Qualche arma in più, oltre a quelle poche che siamo riusciti ad avere, in un clima di controspionaggio e contrabbando.
“Sono otto. Otto per noi e per il centro diurno.”
Sono deluso, ma non stupito.
“Con sedici mascherine che ci facciamo?! Copriamo un turno e qualcosa!”
“No dottore, hai capito male. Otto tra noi e il centro diurno.”
D. non lo sa che le rianimazioni sono piene, lui non sa cosa sia un ventilatore e sta notte dormirà circondato tra i suoi giochi in questa improvvisata vacanza. Non sa nulla delle sue chanche come paziente che presenta numerose comorbilità. Non lo sa, e sono settimane di beatitudine completa, mannaggia a lui e alla sua saturazione. Dormirà sereno questa notte, lui.
Io passerò la notte con i supereroi, sperando di assorbire un po’ di coraggio per affrontare i problemi che domani si presenteranno.