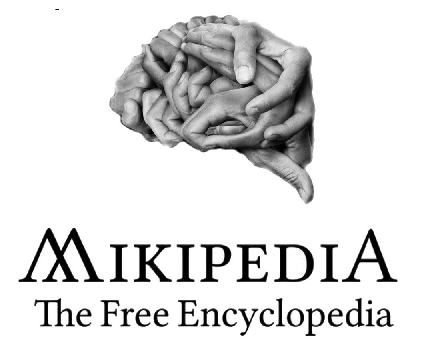Secondo le più accreditate teorie psicologiche l’accettazione del lutto passa attraverso cinque fasi: negazione (non è possibile, non è vero), rabbia (perché proprio a me), contrattazione (se ne esco non farò più gli stessi errori), depressione (non ce la farò mai) e, infine, accettazione.
La profonda modifica delle nostre vite portata dalla pandemia sembra seguire le stesse fasi, ma al rovescio. Siamo partiti, un anno fa, dall’accettazione. Ci è piovuta una catastrofe addosso e ci siamo barcamenati per sopravvivere: chi in casa, a suon di pizze e flash mob dai balconi, e chi in ospedale, tra folle di malati, ventilazioni improvvisate, reparti riconvertiti, lavoratori ridistribuiti. È venuta poi la depressione, multiforme. Chi, dopo aver trascorso mesi in casa, non trovava più il coraggio di uscire, chi ha dovuto ricorrere a psicofarmaci proprio per poter tollerare la convivenza in spazi ristretti, chi è stato trascurato nelle sue patologie di base, chi ha semplicemente visto troppi morti in ospedale. L’estate ha portato una fase di contrattazione quasi gioiosa: possiamo rinunciare ai viaggi lontani, accettare la mascherina, pur di godere dell’aria aperta, del sole, del mare.
L’autunno-inverno, che un tempo designava una collezione di abiti, ci ha invece travolti con una nuova ondata, facendo crollare, per chi ancora l’aveva, l’illusione di aver controllato l’epidemia. L’invenzione dei colori si è portata dietro nuove caratteristiche coordinate. Bianco metafisico (chi mai ci arriverà… solo un’isola con più pecore che abitanti, grazie all’inverno senza turisti), giallo compromesso, arancio esasperazione e rosso rabbia. Le brevi rivolte italiane di novembre, seguite da quelle americane di diversa origine in gennaio hanno messo in luce le fragilità della democrazia e l’esasperazione di una popolazione allo stremo, portando paura oltre che rabbia. «La guerra era peggio» non facciamo che ripetere, ma in realtà continuiamo a sfogliare foto di un paio d’anni fa, che ora sembrano appartenere a un’era lontanissima, in cui eravamo inconsapevolmente felici, immersi in tutt’altri futili problemi e continuiamo a pensare: «perché proprio a me? Perché proprio in questa fase della vita?». Dimenticandoci, in realtà, che in tutte le fasi della vita una pandemia è un disastro. Per gli anziani, che vivono rintanati per paura di ammalarsi gravemente, per chi ha appena finito di lavorare e contava di godersi una meritata pensione con qualche viaggio e i nipoti, per chi sta lavorando e deve reinventarsi per mettere insieme il pranzo con la cena, per chi è giovane e pieno di progetti rimandati a data da destinarsi, per chi ha iniziato l’università e deve aggiungere alle difficoltà dell’ambiente quelle della distanza, per chi è in fase di crescita e ha bisogno dei suoi coetanei, che non può vedere, per i bambini, privati della funzione educativa e sociale della scuola.
La negazione, forse, ha attraversato tutto l’ultimo anno, con picchi più o meno forti: quella da covid è solo un’influenza come le altre, le terapie che fate sono sbagliate, è tutto un complotto delle case farmaceutiche per vendere vaccini. La negazione è figlia del nostro tempo e della risonanza mediatica a cui oggi anche le idee meno accreditate possono aspirare. È la goccia che spesso fa traboccare un vaso colmo di altri problemi.
In ospedale sembra di essere stati proiettati in un videogioco complesso: appena arrivi vivo alla fine di un livello ne inizia uno più difficile. A giugno dell’anno scorso ci lamentavamo quasi perché mancavano i “malati normali” quelli non-covid, ora sembra che il perverso programmatore abbia detto: «Bene, i covid sapete gestirli, e se aggiungiamo anche gli infarti, gli ictus, i traumi e tutto il resto?», «E se arrivassero tutti insieme, a ondate, come gli alieni di Space Invaders?», «E se le ondate fossero imprevedibili?». Così il problema non diventa più convertire i reparti vuoti in reparti che possano accogliere un gran numero di malati covid, ma mantenere doppi percorsi e cambiarli continuamente: chissà se questa settimana serviranno più letti di neurologia, di medicina o di chirurgia? Chissà se serviranno più letti covid o letti normali?
Nell’ultimo mese, nel mio ospedale, il piano adibito a reparto multifunzione è diventato prima osservazione breve per i malati del pronto soccorso, poi reparto di medicina, poi di chirurgia multidisciplinare, al momento è diviso in tre parti: osservazione, medicina e subintensiva covid; l’intensiva covid ha mangiato metà dei letti dell’unità coronarica, un reparto di medicina è diventato di nuovo covid, un piano in ristrutturazione è stato riaperto: il centralino è più confuso di noi. Riceviamo in continuazione telefonate di pazienti e colleghi disperati che sono stati dirottati in ogni dove: «cercavo la chirurgia vascolare». «Non è più qui da tre mesi, la scorsa settimana era al quinto piano, ma forse ora è di nuovo al quarto ma dall’altro lato». Per non parlare degli interventi chirurgici. La sala operatoria delle urgenze era quasi sempre occupata h24 anche prima della pandemia, ha subito una fase d’arresto la scorsa primavera, quando i malati non-covid sembravano scomparsi, e ora ha ripreso con più difficoltà di prima: chi operiamo prima tra la frattura di bacino, l’empiema pleurico, la dissecazione aortica e l’ascesso vertebrale? Il tutto isorisorse.
Sì, qualche specializzando di anestesia e rianimazione, medicina d’urgenza e medicina interna è stato assunto a contratto, ma hanno coperto a malapena il gap di organico che precedeva la pandemia. Così il medico di guardia della medicina d’urgenza è responsabile di 13 letti di subintensiva pulita, 9 di subintensiva covid e 20 di osservazione breve, tutti malati acuti, con elevata necessità di assistenza e ampia probabilità di rapido deterioramento del quadro clinico. Due urgenze in contemporanea sono quasi la norma, rispettare le normative europee dei riposi è praticamente impossibile, la luce in fondo al tunnel è sempre più lontana. Ciò che ha sempre reso più tollerabile il lavoro, immergersi in tutt’altro per dimenticare, un weekend fuori porta, una gita in montagna, un concerto, una cena con gli amici, è vietato. La percezione è quella di camminare sul filo di lana della sanità mentale, di tirare le regole fino allo stremo per ritagliarsi qualche svago in sicurezza, di essere circondati da individui altrettanto esasperati e pronti ad esplodere.
Ma ora ci sono i vaccini! Già… peccato che l’Italia non è Israele e nemmeno gli USA e la campagna procede a rilento. Abbiamo scelto correttamente di vaccinare in primo luogo una categoria ad alto rischio di complicanze gravi e con chance limitate di sopravvivere ai trattamenti intensivi: gli over 80. Ma abbiamo così destinato i rari vaccini altamente protettivi per il contagio a una fascia di popolazione a mobilità limitata con minime speranze di modificare il tasso di occupazione delle terapie intensive e subintensive, in gran parte destinate a pazienti più giovani e sani. Abbiamo poi riservato all’unica categoria di età mista che potrebbe contribuire all’immunità di gregge, quella degli insegnanti, un vaccino che copre benissimo dalle forme gravi, ma avendo più bassa copertura su quelle lievi, probabilmente ha meno efficacia nel bloccare la trasmissione del virus nella popolazione generale. Procediamo alla somministrazione più lentamente del resto d’Europa pur con lo stesso numero di dosi disponibili e, come se non bastasse, gli organi di informazione prediligono in massa i clickbait alla responsabilità civica. Una delle più antiche regole del giornalismo recita che «cane morde uomo» non è una notizia, ma «uomo morde cane» sì. Ci sono dei casi in cui, però, se l’uomo che forse ha morso il cane è uno su un miliardo e il tasso di analfabetismo funzionale è elevato, potrebbe non essere etico dare ampio spazio a una notizia così secondaria. Fare buona informazione è difficile, farlo in un momento storico in cui i numeri sono forse troppi e di certo poco compresi lo è ancora di più.
Da un anno ci aggrappiamo al numero di positivi, al contatore dei morti, all’R0 (che vorrei sapere quanti sanno davvero cos’è), nella vana speranza di comprendere un’epidemia che continuerà a sfuggire a chiunque non faccia l’epidemiologo. Eppure bastava poco, bastava dire che finché proseguirà una delle campagne vaccinali più vaste della storia dell’umanità capiterà periodicamente che alcuni lotti di vaccino siano sottoposti a controlli. Questo accade perché gli eventi improbabili continueranno a verificarsi anche dopo la somministrazione dei vaccini. Il rapporto causa-effetto non è solo temporale (altrimenti ci toccherebbe dire che tutti siamo morti perché siamo stati registrati all’anagrafe), ma l’accertamento del nesso di causalità richiede tempo. In ogni caso stiamo tranquilli, se anche gli eventi avversi fossero confermati sarebbero comunque cento, mille, diecimila o centomila volte meno probabili di morire a causa della covid. Il rischio è insito nella vita, ogni decisione che prendiamo è una implicita valutazione di rischi relativi alle scelte disponibili e della loro accettabilità: attraversiamo col verde perché è più sicuro anche se ci mettiamo più tempo, ci muoviamo in automobile perché è più veloce e comoda, anche se meno sicura del treno e così via. Io spero di vederlo un momento futuro in cui ammalarsi e morire di coronavirus sarà un rischio così ridicolmente basso da non richiedere grandi precauzioni e da rendere inaccettabile il seppur minimo rischio di vaccinarsi. Al momento non è così, e per molto tempo ancora non lo sarà. Chi vi fa credere il contrario distorce la realtà a vostro danno.
Pubblicato originariamente qui