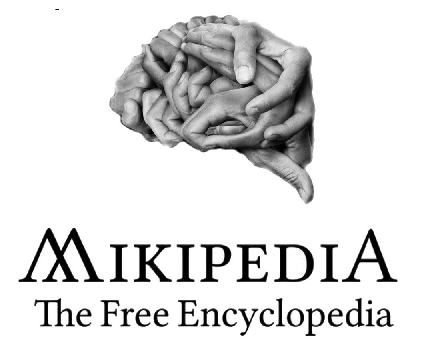– Che giganti? – disse Sancio Panza.
Miguel De Cervantes, Don Chisciotte, cap VIII.
– Quelli che vedi lì – rispose il suo padrone – dalle smisurate braccia; e ce n’è alcuni che arrivano ad averle lunghe due leghe.
– Badi la signoria vostra – osservò Sancio – che quelli che si vedono lì non son giganti ma mulini a vento, e ciò che in essi paiono le braccia, son le pale che girate dal vento fanno andare la pietra del mulino.
– Si vede bene – disse Don Chisciotte – che non te n’intendi d’avventure; quelli sono giganti; e se hai paura, levati di qua, e mettiti a pregare, mentre io entrerò con essi in aspra e disugual tenzone
Da un certo punto di vista una pandemia è un corso intensivo su una malattia nuovissima. Quando mai si ha la possibilità di vedere centinaia di casi della stessa malattia per affinare l’occhio, l’intuito clinico e la terapia? Dalla scorsa primavera abbiamo imparato moltissimo: ad esempio che l’occhio nei pazienti Covid trae in inganno. Ipossia felice, la chiamano, è una delle caratteristiche peculiari della polmonite da SarsCov2 e significa che chi respira male raramente se ne accorge, inducendo in errore anche il medico. All’inizio, abituati ai pazienti ansanti e affaticati di altre insufficienze respiratorie, ci stupivamo di scoprire nei non troppo sofferenti malati Covid saturazioni apparentemente incompatibili con la vita. Ora abbiamo appreso a misurare la quantità di ossigeno nel sangue anche nei pazienti in pieno benessere, a farli camminare sempre, a cercare polmoniti che danno pochi segni di sé.
Abbiamo altresì imparato che quando i pazienti iniziano a sentire fame d’aria è tardi, molto tardi. P., 79 anni, vedova, fragile ma senza grandi patologie, è in questa condizione. La vedo annaspare come sott’acqua, sempre più velocemente, espirare a labbra socchiuse nel tentativo disperato di reclutare alveoli pieni di liquido. Avrebbe bisogno di un ventilatore, di ossigeno ad alti flussi, di una chance, ma oggi non possiamo permettercela. Chiamo i parenti per comunicare loro la brutta notizia: “Ma è sveglia?”. Purtroppo sì, penso, senza avere il coraggio di dirlo. “Possiamo parlarle?” Porgo il telefono a P., che ascolta più che parlare, è sfinita, non riesce a pronunciare due parole consecutive. Al termine della telefonata avvio la morfina, vecchio e affidabile conforto per la fatica respiratoria.
Intanto chiamano i parenti di S., per la seconda volta in due ore: “Come sta? Ci sono novità?”. Ogni medico ha in carico dai 15 ai 20 malati, anche di più nei giorni peggiori. Se non mi fermassi neanche per bere o mangiare ogni paziente avrebbe diritto a venti minuti mal contati del mio turno, da distribuire tra visita, procedure, aggiornamento della cartella, prescrizione delle terapie, ricoveri, e colloquio telefonico con i familiari. Non possiamo permetterci più di una telefonata al giorno, tranne nei casi più gravi. Ma, giustamente, chi ha un parente in ospedale vorrebbe sapere come sta sempre, non ogni 24 ore se va bene.
H. è stato dimesso dal nostro pronto soccorso una settimana fa, con una polmonite non grave e quindi gestibile a domicilio. Dalla polmonite, infatti, è guarito, ma ieri è tornato perchè gli facevano male le gambe e oggi non riesce più a sollevarle. La risposta immunitaria ai virus può talvolta produrre anticorpi che attaccano per sbaglio parti dell’organismo come il midollo spinale, provocando paralisi: il paziente smette di muovere le gambe, poi le braccia e quando tocca al diaframma smette di respirare. Si chiama sindrome di Guillain Barrè e sono stati finora descritti pochissimi casi associati a Covid.
Per questa diagnosi H. è stato sottoposto prima a una TAC e poi a una puntura lombare, ma non basta. Poichè la paralisi galoppa e ora H. solleva a fatica anche le braccia, è necessario iniziare una terapia rapidamente.
“La sua malattia è causata dagli anticorpi che cercano di combattere l’infezione, perchè possa tornare a muovere le braccia e le gambe dobbiamo togliere questi anticorpi e lo facciamo filtrando il sangue. Per filtrare adeguatamente il sangue serve mettere un accesso venoso nell’inguine” Gli spiego. “È d’accordo?”
H. mi guarda, con i suoi enormi occhi mediterranei e neri, e annuisce.
“Le faccio l’anestesia, brucia un po’, ma poi non sentirà più dolore”.
Annuisce di nuovo.
Mentre procedo passo dopo passo a inserire un tubo di circa mezzo centimetro di diametro nella sua vena femorale mi fissa, muto e terrorizzato. È forse il paziente più collaborante sul quale abbia effettuato questa manovra, alla fine mi complimento e gli spiego che a breve dovremo ricoverarlo in un reparto di terapia subintensiva. “Posso chiamare qualcuno dei suoi parenti?”
“Non serve, mio figlio è in Germania, mia moglie non parla italiano”. È solo tra i soli, ma per lui non posso fare altro.
T. è un codice bianco. Alla settima ora di turno, dopo essermi occupata di ogni sorta di emergenze la sua presenza in pronto soccorso un po’ mi disturba. Satura 99%, anche dopo aver camminato cinque minuti su e giù per il corridoio, ha 36,6 di temperatura, non ha neanche la polmonite.
“Sto male da 10 giorni, ho fatto il tampone una settimana fa, è risultato positivo”
“E quindi?” gli chiedo
“Mi sento stanco, non sento gli odori, e poi quando faccio i respiri lunghi dò un colpo di tosse”.
“Sa che nessuno di questi è un valido motivo per venire in pronto soccorso, vero?” mi spazientisco.
“Ma il mio medico non mi risponde, nessuno mi ha chiamato, se ne sentono di ogni sorta su questo virus e non si riesce a capire quando bisogna preoccuparsi”.
Posso capirlo, T.: è ansioso, è abbandonato a se stesso e non può rendersi conto che sta sottraendo tempo e risorse a pazienti più gravi. Il SISP (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica), in Piemonte, ha tempi per la presa in carico dei positivi sempre più lunghi, T. non è il primo a lamentarsene. Non è certo colpa dei medici di base, sovraccarichi di lavoro, se non riescono a stare dietro a tutti. Forse si sarebbe potuto potenziare il servizio di follow up telefonico. Forse si sarebbero potute attrezzare meglio le strutture e creare percorsi ospedalieri dedicati. Forse si sarebbe potuto investire sulle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) e sulla gestione domiciliare.
Invece in pronto soccorso siamo ancora (di nuovo) qui: a dividere il nostro tempo sempre insufficiente tra le vere urgenze, i malati abbandonati e i parenti preoccupati. Dobbiamo ancora (di nuovo) decidere a chi riservare una visita frettolosa, una telefonata in meno, una attesa interminabile, o scegliere come distribuire le scarse risorse, che siano posti letto o presìdi di ventilazione, perché la coperta è sempre più lisa e corta.
Pubblicato originariamente su Volere La Luna