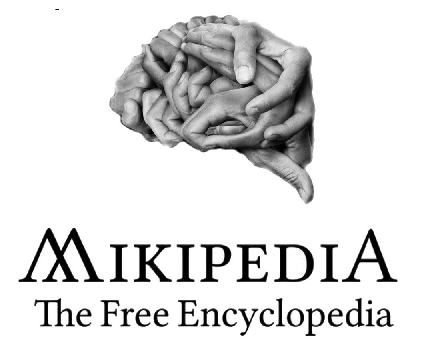La pace regnava sul mondo, le sentinelle non davano l’allarme, nulla lasciava presagire che l’esistenza sarebbe potuta cambiare.
Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari

Nel corso delle settimane a partire da metà febbraio la coda in pronto soccorso si è accorciata sempre di più. Sono spariti prima i codici bianchi, poi si sono ridotti i codici verdi, e dalle classiche 4 ore di attesa siamo scesi a pochi minuti. I corridoi, di solito strabordanti di barelle, si sono svuotati. La notte un clima irreale calava sulle sale d’aspetto vuote. Abbiamo vissuto a lungo un deserto dei Tartari, ma a differenza che nel classico di Buzzati, i tartari sono arrivati.

Quel primo giorno siamo stati subissati di telefonate: “Il marito di mia cugina che fa il camionista è passato da Codogno ma senza fermarsi e poi ci ha portato un pacco di arance, potremmo esserci contagiati?”, “Ho la febbre da tre settimane, devo fare il tampone?”, “Il 1500 non mi risponde e il 112 mi ha attaccato quindi chiedo a voi”. Chiunque avesse un numero interno dell’ospedale l’ha subissato di telefonate, rendendo impossibile l’attività ordinaria. Il centralino mi metteva in attesa, tutti i numeri interni per chiamare i consulenti erano staccati e io non sapevo come rintracciare lo psichiatra, il chirurgo, il vascolare o chiunque altro mi servisse per i miei pazienti non-Covid.

Lentamente il pronto soccorso si è adattato al crescente numero di casi sospetti. All’inizio erano così pochi che bastava la nostra stanza di isolamento per visitarli: l’infermiere mi chiamava dal triage, il paziente veniva accompagnato lungo un percorso esterno fino alla stanza di isolamento, nel frattempo mi bardavo (cuffia, calzari, camice impermeabile, maschera filtrante, visor, doppio paio di guanti), poi entravo nella stanza di isolamento, visitavo e interrogavo il paziente, uscivo, chiamavo l’unità di crisi per l’autorizzazione al tampone e, se c’erano dei criteri molto stringenti, chiedevo il tampone, altrimenti rimandavo il paziente a casa con la tachipirina.
Ben presto la stanza di isolamento non è stata più sufficiente e ci hanno dato 4 stanze al quarto piano (sempre accessibili da percorso dedicato) per ospitare fino a 16 pazienti.
E poi, mano a mano che i pazienti “normali” diminuivano, il covid si è mangiato quasi tutto il pronto soccorso.
Una notte sono andata al lavoro e c’era un muro. Un muro di mattoni a separare l’area covid da quella normale, o, come diciamo noi, lo sporco dal pulito, la zona dove devi vivere con mascherina, guanti, cuffia e camice di tessuto non tessuto da quella dove hai il privilegio di lavorare come un mese fa, con la tutina di stoffa e le mani libere.
Il muro, nota giustamente un collega, sembra quello della copertina di “the wall” dei Pink Floyd.

Ora la zona pulita ha 1 ambulatorio e 1 sala emergenza per 8 posti letto totali, mentre quella sporca ha 2 ambulatori, 1 sala emergenza e una sala di degenza per 18+4 posti totali. I percorsi sono completamente separati e anche la radiologia ha due spazi, separati da muri di nylon, uno per i pazienti puliti, l’altra per i sospetti covid. I pazienti vengono smistati al pre-triage (la famosa tenda) e accedono da due ingressi diversi.
Le due sezioni del pronto non hanno nessun contatto se non per telefono o per radio.
Per limitare al massimo lo spreco di materiale la scorta dei farmaci rimane nel pulito, mentre nella zona covid c’è un carrello emergenze con i soli farmaci e presidi essenziali. Per i farmaci mancanti si chiede alla radio.
“Isolamento a emergenza, passo”
“Qui emergenza, avanti isolamento”
“Serve un keppra in 250 di fisiologica, passo”
“Ricevuto isolamento, lo preparo, passo”
“Emergenza a filtro, passo”
“Qui filtro, avanti emergenza”
“Ti passo il Keppra deflussato, passo”
“Ricevuto emergenza, passo”
“Filtro a isolamento, passo”
“Qui isolamento, avanti filtro”
“Ti lascio il keppra, quando vuoi puoi aprire la porta, passo e chiudo”
Se la situazione non fosse drammatica sembrerebbe di stare a un campeggio scout. Nel frattempo le indicazioni dell’organizzazione mondiale della sanità sono cambiate: per visitare i pazienti con covid sospetto o accertato basta la maschera chirurgica, il visor, un solo paio di guanti e il camice di tessuto non tessuto. La maschera filtrante e il camice impermeabile vanno riservati alle procedure più invasive (tampone, aerosol, ventilazione in maschera, intubazione). Di conseguenza nella stanza emergenza-isolamento-covid c’è sempre un infermiere per prestare assistenza ai pazienti eventualmente presenti, mentre il medico, che va su e giù tra gli ambulatori e la stanza isolamento si cambia di volta in volta.
Fuori dalla stanza di isolamento c’è il “filtro”, una zona franca e semi-pulita con un infermiere che gestisce la radio ed è incaricato di fornire alla stanza di isolamento-covid tutto ciò di cui ha bisogno. Il Filtro fa da tramite tra l’emergenza pulita e l’emergenza-isolamento-covid e tra la degenza-covid e il resto dell’ospedale. Fa i bagni a letto ai pazienti il cui tampone è risultato negativo e che necessitano di ricovero in zone pulite dell’ospedale, sanifica tutto il materiale che esce dall’isolamento e lo prepara all’utilizzo successivo, invia le provette per gli esami e legge i referti alla radio. Quando sono dentro con un paziente, vestita come un astronauta, la sensazione di isolamento è totale, prendere fiato è faticoso sotto alla maschera filtrante, e il suono del respiro mi rimbomba nelle orecchie: mi sembra davvero di essere in una navicella spaziale ad anni luce di distanza da altri esseri umani.
Noi medici di pronto siamo abituati, nelle emergenze, ad avere moltissimi presidi e tantissime mani a disposizione: un paziente grave assorbe spesso tutte le risorse in turno e chiunque passi sa come dare una mano. Moltissime cose avvengono senza che ce ne rendiamo conto e senza una richiesta esplicita: gli infermieri e gli oss sanno benissimo cosa fare, chi cerca un accesso venoso, chi analizza l’emogasanalisi, chi spoglia il paziente e lo monitorizza, chi mette il catetere, chi fa l’ecografia, chi prepara i farmaci: è tutto molto efficiente e rapido. Invece nell’isolamento siamo due: un medico, un infermiere, un carrello emergenza, un attacco dell’ossigeno e un ventilatore. Possiamo chiedere cosa vogliamo, ma la latenza è notevole. Un altro paio di mani richiede 5 minuti di vestizione e 5 minuti, durante un’emergenza, sono eterni. Per chiamare l’anestesista bisogna spiegare alla radio il motivo, far chiamare da fuori e aspettare che l’anestesista a sua volta si vesta. I farmaci richiedono lo scambio radio di cui sopra, bisogna pensare in anticipo, ma anche evitare di sprecare materiale che una volta entrato non può più uscire.

In poco più di una settimana quel muro, che è diventato simbolo della nostra lotta, si è riempito di firme e graffiti. Ci ricorda che siamo uniti, anche se non possiamo toccarci e per riconoscerci dobbiamo parlarci, perché l’unica cosa che spunta dalle divise sono gli occhi e i maschi barbuti si sono rasati per far aderire meglio le mascherine. Già si parla di quando lo abbatteremo, quel muro: chi dice a martellate, chi a pugni, chi a testate. Di quando sgonfieremo la tenda e potremo abbracciarci.
Il resto del racconto e dei diari del reparto Covid sono disponibili qui