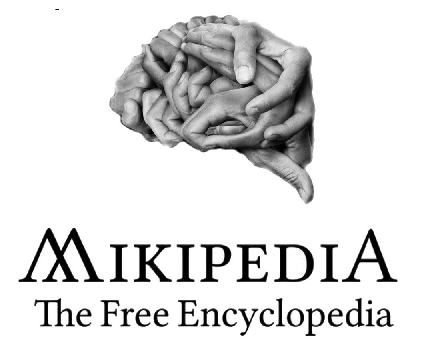Il movimento pro vita ha prodotto recentemente una campagna pubblicitaria che a me, come penso a moltissimi altri lavoratori del settore, ha fatto partire un embolo. Unisce infatti con estrema maestria disinformazione e uso scorretto delle parole, facendo appello a due leve infallibili: i sentimenti e la famiglia. Un piccolo capolavoro di malvagità che merita di essere smontato punto per punto in un lavoro perfettamente inutile di questi tempi nei quali la soglia dell’attenzione non supera la lunghezza di un tweet.
Ingoiate un omeprazolo, uno xanax, date un’occhiata a queste immagini e cominciamo.




Eutanasia dal punto di vista etimologico significa “buona morte” ed è ciò che ciascuno si augura per sé: addormentarsi serenamente nel proprio letto in età avanzata e non svegliarsi più il mattino successivo senza aver mai sofferto.
Raramente, però, chi utilizza questa parola lo fa nel suo senso etimologico. Da anni è infatti utilizzata, in senso positivo o negativo, per indicare un insieme di atti giuridicamente distinti che sono le direttive anticipate di trattamento, il suicidio assistito e l’omicidio del consenziente.
L’etica alla base di questi tre atti è l’autodeterminazione dell’individuo che non può prescindere dalla sua definizione di accettabilità della vita. Ciascuno di noi, ogni giorno, svolge un’implicita riflessione interiore sull’accettabilità della propria vita nel momento in cui, alzatosi al mattino, prende l’ascensore per scendere al piano terra anziché lanciarsi dalla finestra o sale sul tram anziché buttarcisi sotto.
Alcune persone fisicamente sane, talvolta, reputano negativo il bilancio della propria qualità di vita e si suicidano per cause mentali o sociali (si pensi, ad esempio, al direttore di un’azienda costretta a dichiarare bancarotta o al giocatore indebitato).
Il principio etico dell’autonomia, nato, ricordiamo, dopo la seconda guerra mondiale a causa degli orrori dei campi di sterminio, tutela l’individuo assegnandogli la scelta definitiva in campo terapeutico e limitando notevolmente i trattamenti sanitari obbligatori, cioè eseguibili anche contro la sua volontà.
Nell’ottica autonomista il medico è sempre un esperto che consiglia la terapia più adatta, mentre il paziente sceglie se accettarla o rifiutarla. Nella totalità del mondo occidentale se una persona è cosciente e capace di intendere e di volere può liberamente accettare o rifiutare qualsivoglia trattamento le sia proposto, da un’aspirina alla ventilazione meccanica.
Piergiorgio Welby, ad esempio, poteva legalmente scegliere di interrompere la ventilazione meccanica in qualunque momento e ciascun sanitario sarebbe stato deontologicamente obbligato a rispettarne la volontà. Si è montato un caso per nulla.
Il principio dell’autonomia, però, non è onnipotente: ha delle regole ben precise. Posso, in virtù del principio dell’autonomia, decidere di farmi asportare un piede sano? No. E nessun medico è deontologicamente obbligato a fare una cosa del genere. Posso, in virtù del principio dell’autonomia, rifiutare l’amputazione di un piede gangrenoso che so mi porterà a morte certa solo perché non voglio perdere la mia integrità fisica? Sì. E nessun medico può amputarmelo contro la mia volontà. Finchè il paziente è cosciente è tutto molto semplice. Ma cosa accade quando il paziente non è cosciente? Accade che, sul principio dell’autonomia, prevalgono quelli della non maleficienza e della beneficialità: il medico sceglie al posto del paziente ciò che è “bene” per lui, tenendo sempre in mente il “primum non nocere” di Ippocrate. A parole è tutto facile, e nei primi momenti lo è davvero. A nessuno verrebbe in mente di non provare a rianimare un giovane che ha avuto un incidente stradale. Ma qual è il “bene” e soprattutto il “non male” per un giovane che ha avuto un’emorragia cerebrale devastante e che è confinato in un letto di rianimazione non cosciente per il resto della sua vita? Per rispondere bisognerebbe sapere qual è la qualità di vita ritenuta accettabile dal paziente e agire di conseguenza. Per qualcuno potrebbe essere importante anche solo respirare, per altri potrebbe essere ritenuto intollerabile essere accuditi in tutto e per tutto senza potersi mettere in comunicazione con il mondo.
Il principio dell’autonomia, eluso a causa dell’incoscienza del paziente, rientra dalla finestra sotto forma di direttiva anticipata di trattamento: io oggi, che sono cosciente e capace di intendere, dichiaro che se mai dovessi trovarmi in condizioni irreversibili di incoscienza rifiuterei le terapie necessarie a mantenermi in vita. Non posso chiedere di essere ucciso, ma di non essere sottoposto a ventilazione meccanica/nutrizione artificiale/idratazione/terapia antibiotica sì. Proprio come non posso chiedere che mi sia asportato un piede sano, ma posso rifiutarmi di essere amputato di un piede malato.
Le direttive anticipate di trattamento servono anche, o soprattutto, a chi ha una diagnosi di malattia neurodegenerativa dall’evoluzione ben nota e prevedibile come la SLA (sclerosi laterale amiotrofica). Chi soffre di questa malattia sa fin troppo bene che a un certo punto della propria vita smetterà di respirare. Ha, però, tutto il tempo per decidere prima se, quando si porrà l’eventualità, vorrà o non vorrà essere attaccato ad un ventilatore. Potrà anche decidere in un primo momento di sì e, se rimane cosciente, cambiare poi idea (vedi Welby).
È in grado una persona comune di decidere anticipatamente quali condizioni di vita siano da ritenersi accettabili? Se ne può discutere. Come ci si comporta come medici in caso di direttive anticipate prive di senso/ contraddittorie/ mal espresse? Sarà un bel problema. La legge 219 tuttavia tenta di proteggere il disponente prevedendo che il medico possa disattendere le direttive anticipate se palesemente incongrue, in accordo col fiduciario. E a proposito del fiduciario mette contro qui di dire che esso è più importante ancora delle disposizioni anticipate di trattamento, in quanto sarà il fiduciario, in accordo coi medici, a “tradurre” in atti concreti o in concrete astensioni quanto disposto dal paziente.
Passiamo alla questione suicidio assistito / omicidio del consenziente.
Chi è cosciente e fisicamente sano e desidera morire, nel nostro Paese, può legalmente farlo: basta assumere una dose letale di farmaci, lanciarsi da un ponte, sdraiarsi sui binari della ferrovia o scegliere uno tra le altre decine di metodi più o meno fantasiosi messi in atto nel corso dei secoli. Il suicidio in Italia non è sanzionato, come invece avviene o è avvenuto in altre parti del mondo e in altre epoche.
La domanda lecita è se, oltre a non sanzionare il suicidio, per tutelare l’autonomia dell’individuo, lo Stato debba provvedere a facilitare la morte di chi ritiene che le proprie condizioni di vita non siano più accettabili. È il caso recentemente esemplificato da DJ Fabo. Una persona cosciente e paralizzata ad oggi in Italia può morire solo rifiutandosi di bere e mangiare e facendosi supportare con una sedazione palliativa terminale per tutto il tempo necessario. Basta? Non basta? Se ne può discutere.
Alcuni paesi, tra i quali Svizzera, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Oregon, Vermont, Montana, California, ritengono che sia sensato offrire a persone altamente selezionate la possibilità di porre fine alla propria vita qualora ritengano, a buona ragione, la propria qualità di vita inaccettabile.
Si apre quindi lo scenario del suicidio assistito (ti preparo i farmaci e sarai tu a premere il bottone/ bere la pozione/ spingere lo stantuffo della siringa) o dell’omicidio del consenziente (sei paralizzato, mi esprimi il tuo consenso e lo stantuffo della siringa lo premo io).
Può il suicidio assistito/ l’omicidio del consenziente essere applicato indistintamente a chiunque ne faccia richiesta? No. Esattamente come non si può pretendere che ci venga asportato un piede sano non si può richiedere il suicidio assistito per episodi di bullismo. I paesi che lo regolamentano hanno le proprie regole, ma quasi tutti escludono i pazienti psichiatrici e le persone che in passato hanno tentato il suicidio e ne limitano l’applicazione a casi di patologie progressivamente ingravescenti, sicuramente letali e per le quali non esiste più terapia.
Per i pochi che hanno resistito fin qui veniamo alla ragione per la quale sto scrivendo. Da un’associazione che si chiama pro vita mi aspetto una tutela di qualche diritto “in favore di”, “per”, “pro” appunto. Dalla loro campagna, invece, traspira una specie di prevaricazione dei parenti sul paziente. “Tizio può decidere di morire. E se fosse tuo parente?”… sottointendendo un “Come si permette sto stronzo di prendere una decisione senza pensare a me??”
È un sentimento forte, che prende alla pancia (e sappiamo quanto vada di moda di questi tempi) e fa leva su quello che un po’ tutti pensiamo ai funerali (come farò io a vivere senza di lui?) e in particolare a quelli dei suicidi (come ha potuto lasciarmi solo? Come ha potuto non pensare al mio dolore?).
La domanda che ci dovremmo fare è: che diritto tuteliamo vietando l’”eutanasia”? Quello dei parenti a sfavore di quello dei pazienti? E da quando è diventato di moda il diritto di vietare qualcosa a qualcuno? Io, eterosessuale, ritengo mio diritto vietare a te, omosessuale, di sposarti. E che diritto sarebbe? Da cosa mi protegge esattamente? Che poi gli individui abbiano diritto o no di morire o gli omosessuali abbiano diritto o no di sposarsi è una questione da discutere. Ma di certo in nessuno dei due casi vietarlo è “diritto” di qualcuno.
Tornando al funerale del suicida, la domanda corretta da porsi dovrebbe essere “quale dolore stava vivendo dentro di sé se non ha pensato al mio e a quello di tutti gli altri e ha preferito morire che continuare a vivere?”.
In quest’ottica un vero movimento pro vita non dovrebbe combattere l’eutanasia, ma sostenerla. Cosa, più della garanzia di una buona morte, è di stimolo per continuare a vivere?
La partita bioetica è apertissima e le domande superano di gran lunga le risposte, ma per fare dei passi avanti bisogna di certo evitare messaggi distorti, così facili da veicolare e difficili e faticosi da smantellare.