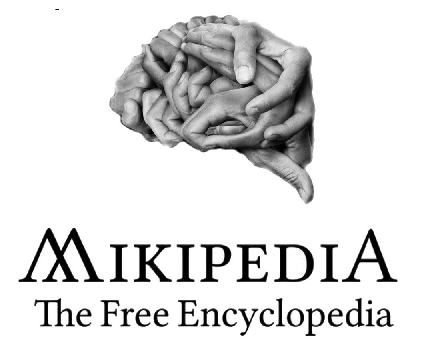Potrei aver trascorso l’ultimo giorno di studio della mia carriera universitaria al Valentino, in un tripudio di luce e profumi,
circondata da torinesi che scoprono in massa la primavera, bambini che corrono e imparano ad andare in bicicletta, canoe che passano con dolce sciaguattio di remi, istruttori che sbraitano nei megafoni, ragazzi che prendono il sole, giocano a schiaccia 7, suonano lungo il fiume o danno spettacolo di giocoleria e funambolismo.
Non credevo che studiare in primavera fosse così crudele, più che a luglio, perché d’estate in fondo fa troppo caldo per poter godere appieno delle giornate e rinchiudersi in una vecchia biblioteca dagli spessi muri di mattoni può quasi sembrare un’idea allettante.
Essere costretti a snocciolare indicazioni chirurgiche mentre la natura si risveglia e la brezza porta odore di fiori e carne alla griglia, invece, non fa che peggiorare la riluttanza che provo ad abbandonare il mondo universitario, accogliente e
animata casa degli ultimi sei anni.
Ma questo dolce lungo addio alla vita da studente che si protrarrà in ogni caso per i prossimi tre mesi non poteva che iniziare dalle
stesse pietre da cui un concittadino a inizio secolo cantava “Gli studi son già terminati abbiamo finito così di sognar”.